

L'Italia perde la sua autonomia fin dal 1494 con l'entrata di Carlo VIII e con la Pace di Cateau-Cambrésis del 1559 che dà alla Spagna il governo e l’influenza sulla maggior parte dei suoi territori.
Pur tenendo conto della nuova situazione, degli effetti delle nuove rotte commerciali e della nascita di nazioni europee, alcuni storici considerano che il periodo del Seicento, parallelo alla situazione culturale del Barocco, non determina una decadenza italiana vera e propria1. A questo proposito Fernand Braudel, lo storico che maggiormente ha contribuito a creare questa nuova visione:
La crisi di quel sistema, infatti, è lunga e attraversata da congiunture medie e brevi che non permettono di definire una data certa al cambiamento né una decadenza definitiva del gruppo di Stati "perdenti". Infatti accade che la crisi venga avvallata o ritardata da varie congiunture quali: la piccola glaciazione3 che sconvolge la meteorologia del Seicento determinando periodi di carestia, epidemie e varie difficoltà (sembra che proprio per questo in quegli anni vengano preferite le vie di terra), la <<guerra dei trent’anni>> che sconvolge i traffici mercantili Nord-Sud, la lotta della Controriforma che ha effetto sul comportamento politico dei vari stati e sul pensiero generale del periodo, lo sfruttamento delle colonie d'Oriente e d'Occidente che cambia il volto dell'economia europea, la ripresa demografica dopo la metà del secolo, la piccola ripresa economica dopo gli anni trenta, più tutta una serie di avvenimenti che sottolineano ora l’una ora l’altra tendenza.
In campo economico si fa sentire sempre più la differenza tra stati in crescita, la cui strutturazione come stati nazionali pur partendo da una situazione difficile e povera consente una risposta innovativa e al passo con i tempi (Inghilterra, Olanda, Francia) e stati che ancora si reggono su vecchie strutture già collaudate e non dispongono della libertà e della forza per rinnovarsi, quali la Spagna, la Turchia e l'Italia che essendo stata al centro dell’economia di scambio del Trecento e Quattrocento, dispone di enormi ricchezze accumulate, e di mezzi già provati, utili per sfruttare il nuovo assetto determinato dai mercati delle colonie e dall'arrivo di metalli preziosi dalle Americhe4.
Se da una parte vi è una tendenza a tesaurizzare gli enormi guadagni che il secolo precedente aveva permesso5, o investendo in opere costruttive o in metalli o in terre, dall'altra il surplus di ricchezza e le trasformazioni operate per fare fronte alle nuove esigenze del mercato6 permettono agli italiani di mettersi ancora in gioco: con istituti di prestito e cambio (fiorentini, veneziani e genovesi compaiono in tutte le piazze europee, il Banco di Rialto tiene fino al Settecento come piazza di scambi e alla fine del Seicento Venezia mantiene un traffico che perlomeno si eguaglia a quello dell'inizio del secolo7, mentre Genova se è vero che detiene il monopolio delle finanze spagnole fino al 1654, è provato che rimane un importante centro di scambio fino alla fine del XVIII secolo8) e sfruttando le strutture già navigate per cavalcare le situazioni. Infatti pur subendo in pieno lo spostamento dei traffici fuori dal Mediterraneo e la sottomissione alla Spagna, l'Italia acquista, con questo, un periodo di pace relativa e rimane uno dei terreni di gioco più importante, da dove passano le truppe spagnole dirette ai Paesi Bassi, dove si reclutano soldati per le varie guerre del Nord (guerra dei trent’anni) o contro i Turchi, dove si scontrano gli interessi francesi e spagnoli (guerre per il Monferrato, guerre per la Valtellina, scontri in campo piemontese, rivolta di Messina …) e dove, in definitiva, si incanala e passa ancora gran parte dell'oro spagnolo9. La Spagna poi pur dissanguando con dazi e tasse i territori sottomessi, determina sì uno sfruttamento, ma non una marginalizzazione ed un impoverimento immediato10. La situazione quindi si mantiene vitale. Secondo Braudel11 e altri storici12 Venezia e l’Italia non decadono propriamente fino al 1650/80. Il Braudel: <<Dicevo nel 1949 che il declino non mi sembrava visibile prima del 1620. Oggi preferirei dire, senz'essere affatto sicuro, non prima del 1650.>>, aggiungendo quasi subito: <<bisognerebbe scegliere una data tardiva: 1650 o persino 1680>>13.
Nessuna delle inflessioni del periodo sembra poter essere attribuita a una "crisi generale del XVII secolo". Il paradosso, o l'eccezionalità dell'Italia sta nell'aver realizzato assai presto, e in anticipo sul resto dell'Europa occidentale, le principali trasformazioni per passare dal feudalesimo al capitalismo, traendone partito per delineare un modello di sviluppo precoce e originale. È questo modello che si esaurisce, per certi versi già nel XVI secolo e in generale nel secolo seguente, vittima delle sue stesse contraddizioni. Solo le manifatture registrano un calo assoluto, tutti gli altri settori, per Aymard, suggeriscono l'esistenza di involuzioni relative e perdite di mercato, di un restringimento degli orizzonti ma non del volume del commercio esterno, di progressi in qualche settore particolare, di brutali cadute seguite da recuperi, di ristrutturazioni avviate e riconversioni riuscite, tenendo conto del fatto che esiste una continuità di fondo, un mantenimento delle vie scelte nel secolo precedente, specie nel campo dell’agricoltura. La situazione non suggerisce affatto un regresso generalizzato dell'offerta e della domanda globali, calcolate in termini monetari o in quantità di beni e di servizi prodotti e scambiati.
Ciò che è cambiato è che l’Italia non domina più la partita, anche se la ristrutturazione complessiva lascia alle città del Nord Italia un’enorme ricchezza14.
Questa ricchezza accumulata e mantenuta viva con strumenti vari che garantiscono la buona salute della penisola (si vedano le varie conversioni attuate dagli Stati italiani, soprattutto nel campo della produzione manifatturiera e di quella agricola, che non era ancora minoritaria in Europa, assieme alla vendita delle Rendite e dei Privilegi in Toscana, Stato della Chiesa e Veneto15, che garantiscono un equilibrio di entrate, almeno fino a quando l'economia non si trasforma totalmente in industriale, ossia nel Settecento16), garantisce l'esploit culturale italiano che va sotto il nome di Barocco e che pur avvalendosi anche di apporti stranieri, acquisisce grandi innovazioni in campo scientifico, letterario, musicale e artistico, basi per lo sviluppo successivo in ogni campo, che trasferirà il suo centro conduttore in Francia solo nel secolo successivo.
Basti pensare alle ville venete, ai palazzi romani e alla Renovatio della città simbolo della nuova fede controriformista, ai teatri che nascono ora come nuova istituzione pubblica, alle pubblicazioni in tutti i settori del sapere e alle varie Accademie letterarie, artistiche e scientifiche.
A Venezia e nel veneto la situazione non è diversa, anzi, essendo l'unico stato italiano veramente autonomo troviamo che la maggior parte delle istanze innovatrici hanno contatti con il suo mondo (Galileo, Sarpi, Cremonini, Velàzquez, Rubens…).
Economicamente le strutture della Repubblica garantiscono un'alta qualità di scambi per tutto il Seicento. Pur sentendosi pesantemente le varie crisi congiunturali, quali le carestie, gli attacchi della peste e del tifo, la crisi dei prezzi degli anni venti e quella determinata dalla <<guerra dei trent’anni>>, le situazioni di pressione politica quali le guerre con i Turchi, le ingerenze spagnole e della Chiesa, e quelle dell'Impero Asburgico, vengono messi in atto vari mezzi di risposta: il passaggio dell'aristocrazia alla terra (ruralizzazione assecondata dallo Stato veneziano), l'apertura del Banco di Rialto, l'utilizzo delle navi straniere, l'elaborazione del prezzario, l'utilizzo di una economia di scambio regionale e di autosussistenza, lo sfruttamento dell'industria manifatturiera anche nelle zone dell'entroterra (Vicenza ad esempio è il centro di maggior produzione di panni-seta di media qualità19, i centri minori acquistano così un peso maggiore ed una distribuzione di ricchezza che ne garantisce la floridezza anche culturale, pensiamo a Treviso, Vicenza, Verona e Padova con la sua scuola aristotelica), rivalutate per le spese di manodopera e per la produzione di materie prime20. Fin dal 1550 Venezia aumenta gli interventi sulla terraferma (bonifiche, sfruttamenti mirati...) inoltre attua tutta una serie di scelte per aumentare il controllo da parte della Capitale sulle élites cittadine dei capoluoghi e sulla concorrenza interna dell'entroterra nella produzione, utilizzando, ad esempio, la creazione di distretti, provveditori, inquisitori21.
Nei patrimoni delle maggiori famiglie la terra acquista un peso sempre maggiore e rappresenta una garanzia per la ricchezza, e inoltre anche uno dei requisiti per l’ascesa sociale. In veneto gli acquisti di terra da parte dei nobili raggiungono nel Seicento la metà delle terre disponibili22.
La ricchezza è, dunque, ancora presente (tanto che sembra di vivere in un'isola felice, pur sentendo la sensazione di essere sulla difensiva23), e garantisce una situazione oziosa nella città, dove la cultura può godere degli investimenti necessari al suo mantenimento in grande stile. Pensiamo ai palazzi delle famiglie aristocratiche su Rialto, alle varie ville costruite ai tempi del Palladio e successivamente (ben 332), che pur seguendo la tendenza alla ruralizzazione della nobiltà si caratterizzano poi come raffinatissime ville di ozi più che strumenti di controllo del lavoro sui fondi24.
Qui molti testi importanti e spesso espressivi di forme libere di pensiero vengono stampati durante tutto il Seicento, e Venezia è poi anche il primo polo di sviluppo della nuova produzione teatrale e del Melodramma/Opera, qui viene costruito il primo teatro aperto al pubblico (seguito da altri tre) ed è qui che ancora nel Settecento verranno costruiti vari teatri, dove il mito di Don Giovanni e le "prodezze" di Casanova troveranno casa, dove Goldoni nelle sue opere ci trasmetterà ancora questa sensazione dell’"isola felice"25, e dove Piazzetta, Canaletto e Tiepolo manterranno alto il livello artistico.).
Ancora Braudel scrive:
Bisogna capire ora se questa vita ricca che sembra proprio esprimere il disagio e la decadenza di sottofondo, ossia questa vita di dissipazione delle ricchezze accumulate all'interno di un'isola di libertà circondata dai suoi detrattori e continuamente impegnata a difendere la sua situazione contro attacchi anche molto pesanti (in definitiva Venezia era l'unico stato italiano che non si appoggiava totalmente su uno stato nazionale europeo, che aveva garantito un movimento economico di livello europeo e che si confrontava alla pari con gli imperi europei e dell'est), possa aver determinato una linea culturale di evasione29.
Pensando alla stretta morale e culturale determinata dalla controriforma, con i gesuiti e l'Inquisizione (riammessi a Venezia nel 1657), e a quella politica, economica e sociale determinata dalla nuova situazione europea e dal controllo spagnolo su gran parte dell'Italia, notiamo che dopo i grandi pensatori dell'inizio secolo (Campanella, Galielo, Sarpi) che avevano anche reagito direttamente alla situazione, la vitalità culturale, tralasciando le produzioni gesuitiche e dalla parte cattolica, sembra tendere alla creazione di mondi altri, spesso mitologici, in cui sia il simbolismo, sia l'inserimento di oggetti ed elementi realistici distaccano l'attenzione dai grandi temi metodologici e strutturali30.
Pensiamo alle Accademie, così sviluppate nel Seicento, che proponevano un livello di cultura slegato dalla realtà e che si evidenziava per la pochissima influenza, di ogni singola accademia, sulla società e il dibattito culturale (a parte alcune eccezioni come quella della Crusca e del Cimento)31; oppure consideriamo la tendenza della ricerca scientifica dopo Galilei alla sperimentazione pura, senza implicazioni teoretiche32; persino un intero campo culturale innovativo come il teatro ed il melodramma sembra portare dentro di sè la spinta verso la scenografia, e lo sviluppo di temi mitologici o pastorali avulsi dalla realtà contemporanea o con pochi velati riferimenti, vediamo la lirica, la produzione letteraria di prosa con lo sviluppo del romanzo, la creazione di grandi temi mitologici o di serie di capricci e invenzioni nell'arte figurativa, tutto questo sembra costruire un mondo più alto del livello reale, raffinato ma sganciato, in cui fonemi del linguaggio più utilizzato sono le raffigurazioni mitologiche classiche e la dissimulazione o l'astrazione sono la tendenza prevalente (Torquato Accetto, Sarpi, Marino …).
Non scordiamo che il medium a cui una società fa riferimento per trasmettere i suoi diversi contenuti passa lui stesso il suo messaggio.
Anche i grandi avevano strutturato le loro proposte attraverso figurazioni simboliche e mitiche (La città del Sole...) e pur esistendo comunque una tendenza individuale di ribellione che poteva esprimersi con simbologie dissimulate, rimane che l'effetto generale porta ad una fuga dalla condizione reale che si vive... emblematico che la nobiltà veneziana smetta di essere imprenditoriale e i commercianti del porto divengano per la prima volta una classe borghese diversa dall'aristocrazia, che invece tende a questo "invillamento", a ritirarsi in ville magnifiche, simboli di una passata classicità e quindi di un glorioso passato mitico.
A questo proposito Braudel:
Nel Seicento a livello culturale se sul piano scientifico c'è un distacco tra magia e scienza superando la dimensione platonica umanistica della ricerca naturale arrivando con il campione Galileo alla autonomia della ricerca scientifica dalla filosofia e dalla morale (e questo non fu scevro di effetti politici), sul piano letterario e figurativo si sente sempre più la distanza tra il nuovo mondo estremamente più vasto e dispersivo e la struttura della cultura classica (da qui il senso profondo della "querelle tra antichi e moderni"35).
Le guerre, l'instabilità politica e morale/religiosa, la scoperta di nuovi immensi territori, l'innovazione industriale, la ricerca scientifica e la nuova dimensione cosmica, i nuovi mondi visibili con il telescopio e il microscopio, la caduta del razionalismo costruttivo Rinascimentale ed ancora Manierista determinano un senso di Incertezza e Meraviglia. Da una parte si cerca di adeguare gli strumenti espressivi con una sperimentazione attiva che porta al romanzo alle nuove forme musicali e teatrali e alle forme barocche36, dall'altra si tenta di esprimere questa meraviglia oppure di afferrare ciò che si sente sfuggire e deperire ed ecco il carnalismo e il sensualismo (in senso erotico e di percezione sensoriale) paralleli alle visioni di morte e "memento mori", e anche il realismo (non certo assimilabile a quello ottocentesco, mancandogli completamente una coscienza reale e sociale, pur essendoci sprazzi del genere in Salvator Rosa pittore e scrittore, nel Bamboccio, in Michelangelo B. il Giovane e in Basile) che però si esprime come micro-realismo di particolari, forse per l'incapacità di confrontarsi con i grandi temi della realtà, e la preferenza ad agganciarsi a singoli oggetti di uso comune, infine le favole pastorali e mitologiche: un mondo astorico che proprio per questo garantisce la sua immortalità e non decadenza37.
Paul Renucci:
Si tende a mascherare (Sarpi parlava dell'uso della maschera) e a mediare (l’Accetto nella sua "La dissimulazione onesta" del 1641 parla di "viver cauto…" e Galielo accetta di abiurare nel 1633) oltre che a compensare con l'immaginazione: teatro metaforico e mondi immaginari, liriche e Utopie filosofiche (Adone come metafora epicurea e sensista, La Città del sole, Utopia, La Nuova Atlantide)41. Esiste però una tendenza individuale a reagire al conformismo della controriforma e vi sono anche ribellioni individuali, anche se più nel segno di una affermazione personale: Campanella, G.Bruno, Caravaggio, S.Rosa, Sarpi, Chiabrera, Marino, Testi, E.Davila, B.Dotti, A.Stradella, C.dè Dottori...42
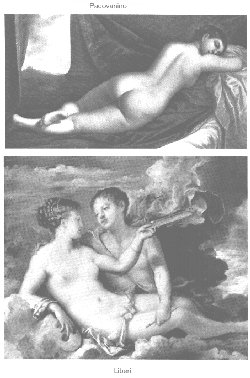
D’altra parte la Chiesa stessa, dopo il periodo prettamente controriformista tra fine Cinquecento e inizi Seicento, finisce col venire a patti con la "peccaminosità" umana, e a consentire un rapporto anche materiale con la vita: gli stessi gesuiti saranno d’accordo nell’utilizzo di forme piacevoli per trasmettere contenuti di fede, e nelle stesse dottrine si inserisce il pensiero che anche questa vita vada vissuta in maniera "piacevole", ossia assecondando i sensi, anche se all’interno delle regole morali (ad esempio si accettano di nuovo il ritratto, e il poema che esaltano le virtù del principe o del nobile, il collezionismo di opere "belle", ambienti e situazioni non del tutto lecite come a Venezia, rapporti con artisti protestanti, etc.)44.
La letteratura del periodo risente dell'adattamento alla nuova situazione sociale, lo sperimentalismo è lo strumento principale della ricerca di una forma espressiva adatta, inoltre la struttura centrifuga della nuova cultura che possiamo definire ormai pienamente moderna, non permette forme fisse, ma piuttosto uno scontro continuo di esperienze e scelte diverse. In questo periodo in tutti campi troviamo innovazioni e produzioni contrastanti: la linea marinista e la contraria, quella sensista e la risposta controriformista e moralista, l'esaltazione dei classici e la risposta modernista, il galileismo e la tradizione aristotelica...
Possiamo dire con Braudel, che sembra un fatto storico che nel momento
in cui uno stato dopo un periodo di grandezza politica ed economica decade,
<<la caduta provoca una molteplicità di splendori. […] In
questo senso, la notte, una certa notte è caduta due volte almeno
sull’Italia: intorno al 1450 e intorno al 1600. Tutto il cielo d’Europa
ne fu illuminato>>46.
3.Il Seicento artistico: il Barocco
Il Barocco o "i Barocchi": come dice H.Hauser (ricordandoci Chastel e tutta una linea culturale che negli anni sessanta portò nuova coscienza nella critica dei vari centri culturali diversi) non esiste un solo Barocco, anzi le stesse espressioni che caratterizzano il periodo definito tale possono essere viste come contrapposte alle qualità che di solito si attribuiscono a questa espressione artistica47.
Nicola Spinosa afferma:
In questa epoca la fruizione artistica è cambiata, i gruppi culturali e sociali sono tanti e variegati49. Gioca in questa varietà la crisi dei valori, determinata da tutta una serie di novità che caratterizzano il secolo: la scoperta di nuovi mondi avvenuta nel secolo precedente, le scoperte scientifiche, da Copernico a Keplero e Galielo che man mano pongono la terra e l'uomo sempre più all’interno di un enorme, infinito universo, sia macro che micro (ricordiamo l’utilizzo del microscopio da parte di Galileo), la conflittualità religiosa nata dalla Riforma e dalle risposte della Chiesa cattolica, le trasformazioni dei rapporti tra individui e Stati assolutistici, sempre più posti in dimensioni nazionali. Tutto questo non permette più alle convinzioni fisse, strutturate nei secoli in sistemi (da quelli medioevali a quelli di recupero classico umanistici), di poter rispondere adeguatamente alle nuove esigenze dell'animo e dell'intelletto umano50.
L'humus culturale era lo stesso per ognuno, e anche i problemi, ma il portare la percezione al livello immediato dei sensi, senza più condizionamenti a priori di concetti intellettuali precostituiti, il caratterizzare il nuovo rapporto tra individuo e Stato, individuo e natura e individuo e religione, come dialogo e acquisizione di strumenti per rapportarsi con la realtà cangiante del secolo, tutto questo porta ad una estrema differenziazione delle singole risposte.
Non era tanto una tecnica al servizio di un contenuto morale (controriformista), ma una qualità dell’arte, che non era più uno strumento di ricerca oggettiva e personale dell’artista, ma una "convenzione", un rapporto tra il pubblico e il professionista, che rifletteva nell’opera la devozione dei guardanti.
Quindi l’arte creava uno scenario alla vita reale degli uomini di ogni classe, che si riconoscevano in quella scena e accettavano di farsi coinvolgere e persuadere52.
Per operare questo occorreva utilizzare tecniche adattabili, fare dell’arte una Retorica (in grado di trasmettere contenuti diversi con una buona tecnica oratoria, da cui il successo che ebbe il De Oratore di Cicerone, e la Poetica e la Rettorica di Aristotele), celare l’artificio, trasformare la ricerca culturale artistica in ricerca propriamente stilistica53.
Da qui nasce spontanea la specializzazione degli artisti, la scelta più libera del proprio modo di costruire la "scena" barocca, il convivere su piani alti delle linee principali e l’ampliarsi di tutto un sottofondo di opere di genere54.
Il collezionismo degli amatori borghesi, degli antiquari, degli stranieri o dei cardinali e dei re, garantiva la sopravvivenza di tutte le espressioni artistiche, mentre a livello si committenza alta si alternano le scelte e le preferenze, soprattutto tra linea classicista e linea "barocca"55.
Inoltre al mondo cattolico-controriformista e alla grande committenza romana si oppongono varie linee di dissenso, a cui partecipano molteplici istanze.
Se il razionalismo unito allo scientismo fanno parte di una di queste per le caratteristiche della ricerca empirica, per il naturalismo di fondo e per l’autonomia dalle impostazioni teologiche che esso sottende, partecipando così alla tendenza naturalista (caravaggisti, bamboccianti e generi "realisti"), dall’altra parte gli scenari pittoreschi, protoromantici, del Rosa e del Castiglione, la branca del magico che all’inizio trovavamo unita alla ricerca scientifica, e le istanze libertine, epicuree e stoiche unite al recupero del classico nella direzione arcadica compongono una varietà di linee che sfuggono ai dogmatismi dei trattatisti, delle Accademie (in primis quella di San Luca), alle scelte dei committenti della "maniera grande" e delle corti, e vanno ad arricchire le scuole locali, gli ambienti liberali e oziosi (Venezia), e le collezioni particolari dei cultori dei generi56.
Non dobbiamo dimenticare che i generi stessi nascono con una tradizione culturale alle spalle che alle volte nasce fin nel XV secolo e che, almeno all’inizio, tutti tendono a valorizzarsi attraverso riferimenti letterari, immettendo contenuti simbolici, ermetici, e metafore nelle scene che poi diverranno di genere puro tra la fine del secolo e gli inizi del Settecento.
Le tre tendenze principali del Seicento artistico si possono schematizzare in: naturalista, classicista e "barocca". Esse hanno legami stretti, si fondano su medesimi problemi di base e nascono da due scelte fondamentali: la visione dell’arte pittorica come ut pictura poesis, con tutte le implicazioni di valutazione dell’operare artistico in termini di arte liberale e la caratterizzazione dell’artista come professionista e ideatore, ben distinto dal mestierante, e il nuovo rapporto con la natura57.
Il recupero e l’utilizzo del passato, sia in termini figurativi e stilistici, sia letterari e contenutistici, è comune a tutte le tendenze del periodo, così come l’interesse per gli elementi realistici e la costruzione di strumenti adatti a "persuadere" il pubblico.
Infatti, la possibilità di scegliere strumenti diversi al servizio della qualità sociale dell’artista porta all'utilizzo di elementi realistici (quasi argomenti dimostrativi di un discorso retorico) e al recupero differenziato della storia, ossia degli elementi classici, in maniera non del tutto differente dal recupero manierista o rinascimentale, ma utilizzato diversamente: da una parte lungi dall'essere tanti elementi singoli orchestrati da una struttura concettuale e prospettica unificante, sono particolari che vengono assorbiti dalla sintesi barocca58, dall'altra questo recupero è vissuto come <<sviluppo ed estensione, reinvenzione della cultura classica.>>59.
D'altra parte se è vero che la spazialità aperta e illusiva di infinito era già una delle espressioni dell'arte cinquecentesca (Correggio, P.da Cortona e Lanfranco), se la capacità di esprimere visivamente il sentimento della vitalità e varietà e molteplicità del reale affonda le sue radici nel Baccanale di Tiziano e nel Festino degli dei di Bellini, è pur vero che tutte le correnti del Seicento suggono elementi formali e sensibilità dal ricco mondo cinquecentesco, Rubens, che è considerato il primo rappresentante barocco, si inserisce in quel movimento neoveneto che nato a Roma agli inizi del secolo esporterà le sue scelte nel resto d'Italia e direi d'Europa (vedi i collezionisti inglesi a Venezia verso la metà del secolo) dagli anni trenta ai cinquanta del secolo.
La scelta del suo iniziatore, il Caravaggio, sta nell’utilizzare <<solo il vero come maestro>>, solo la natura. Però lungi dall’essere mera riproduzione fotografica o oggettiva:
Su una direttiva affine muovono, in particolare, gli "epicurei" e gli "stoici", i quali perseguono una "metafisica" di carattere panteistico e religioso.61
Se la linea naturalistica di Caravaggio possiamo vederla nell'arte come mimesis, non va perso il livello trascendente e religioso che la compone: la luce caravaggesca è si veicolo sensorio, ma anche trascendente e divino, e mentre scopre la natura ne rivela l'essenza positiva ed etica contro il negativo dell'ombra.62
Non scordiamo poi, l’importanza del carattere razionalistico ed empirico del naturalismo, in cui alla metafora usata dai classicisti, si preferisce l’emblema, facilmente percepibile e che non deforma la realtà dell’oggetto rappresentato63.
Ma da Caravaggio ai suoi continuatori sembra si ripeta la storia di Galielo: l'etica naturalistica si trasforma nel suo contrario, in un gergo naturalistico senza implicazioni trascendenti.
Del resto dallo stesso fondo comune partono tutte le pitture di genere che trattano temi realistici: natura morta, vita reale, bambocciate…
Negli anni trenta diviene prevalente, come committenza alta a Roma, il nuovo dipingere "barocco". Qui sembra esprimersi al meglio il discorso legato alla persuasione e all’immaginazione. L'opera barocca ci coinvolge, ci trasporta e ci fa partecipi di una dimensione spaziale che va al di là di limiti reali e fisici, anzi utilizza proprio i suoi elementi costitutivi mettendoli a confronto ed in contrasto organico (pieni-vuoti, finito-infinito, ombra-luce) e trasmettendo con ciò la dimensione di una "concreta e infinita continuità spaziale".
I sensi possono sollecitare il sentimento di fede, ed ecco l'arte come strumento di propaganda, all'interno di una <<politica del consenso>>, anche se non si può vedere tutta la "macchina" barocca al servizio di contenuti morali, va ricordato il rapporto libero, creativo dell’artista con il pubblico, dal quale trae egli stesso i contenuti per la sua composizione "retorica", per la dimostrazione in sé stessa, che, facilmente, è il suo vero ed unico fine66.
Certo è che l’arte barocca, a tutti i livelli, partecipa della rinnovata sensibilità:
Più che il vero essi cercano il verosimile, un vero intellettuale che conciliasse naturalismo e ideale classico, in cui gli elementi reali fossero scelti per giungere ad un equilibrio formale che potesse trasmettere la bellezza ideale.
Spesso la metafora e l’allegoria è il filtro contenutistico più usato, e le fonti formali sono chiaramente distinguibili grazie alle "citazioni" dirette.
Questa linea si inserisce in una tradizione molto lunga, che partendo dal recupero umanistico e rinascimentale, arriva a quello neoclassico del Settecento, anche se vi è una diversità tra i modi di recupero delle forme classiche, in questo periodo, infatti, va inteso come classico romano e greco, e mediazione classica "moderna", ossia quella operata da: Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Correggio, Veronese, dei quali sono recuperate le ricerche formali e le dimensioni stilistiche.
<<Se la storia è il percorso finora compiuto dall'umanità verso la salvezza, bisogna proseguirlo: fermarsi, tornare indietro è peccato. Ecco la differenza culturale del Rinascimento, il ritorno all'antico.>>69
Quello che si chiamerà il "classicismo barocco" non sarà imitazione, ma sviluppo della cultura classica.
I Carracci sono gli iniziatori, la meditazione sull'arte antica, sui modelli del passato, tipica di Annibale, sviluppò infatti una poetica classicista passata in eredità ai suoi seguaci. Ai primi del secolo e soprattutto nel secondo decennio, il movimento classicista vide la formulazione teorica da parte di monsignor G.B.Agucchi (a cui seguiranno poi i maggiori sostenitori di questa linea: Mancini e Bellori) che sosteneva il principio della necessità di una selezione ideale entro il dato naturale.70
Gli autori dei trattati più importanti del periodo possono essere così schematizzati:
classicisti: Scamozzi, Agucchi (Maccati), Passeri, e Bellori;
storici: Baglione, Baldinucci, Bottari-Ticozzi, Scannelli, Boschini, e Mancini;
moralisti: Paleotti, Borromeo, Ottonelli con Berrettini, e S.Rosa nella sua terza Satira;
modernisti: Orlandi, Lanzi, e A.Pozzo.
Se è vero che la scelta classicista poteva rispondere alle esigenze
di rigore e chiarezza, senza dare adito a contenuti "dissenzienti" o controcorrente,
del potere assolutistico e gerarchico, è anche vero che essa per
sua natura si basava su contenuti laici, per cui: le corti europee ben
si adattarono ai suoi modi, specialmente quella di Francia dopo la metà
del secolo, ma la Chiesa ebbe invece vari cambi di direzione e la scelta
definitiva che garantiva il successo di questa linea, avvenne attorno al
1660, periodo in cui con il principato del Maratta alla Accademia di san
Luca e il trattato di Bellori, le sue scelte furono vincenti, anche se
ormai le sue forme passarono al nuovo modo razionalistico e neoclassico
che ne decretò il successo nel Settecento.
Alessandro Mazzoli
NOTE:
______________________________